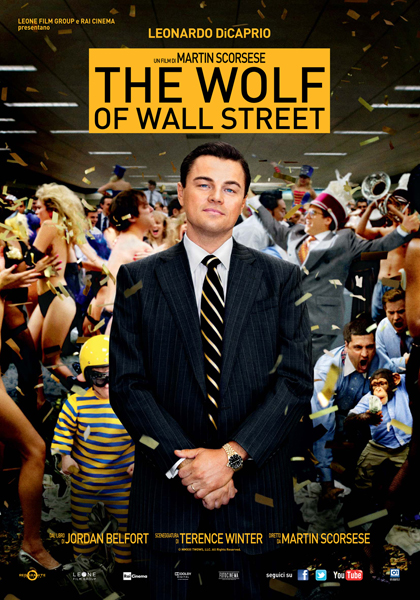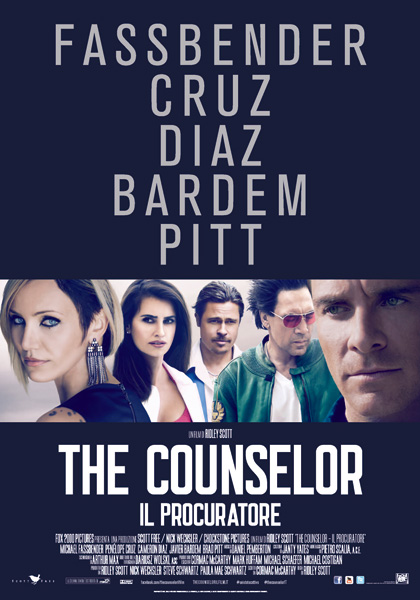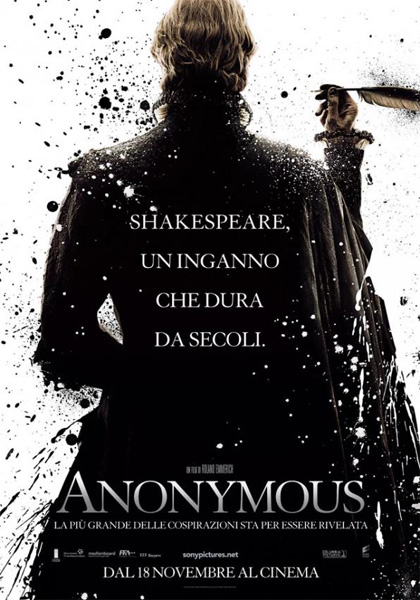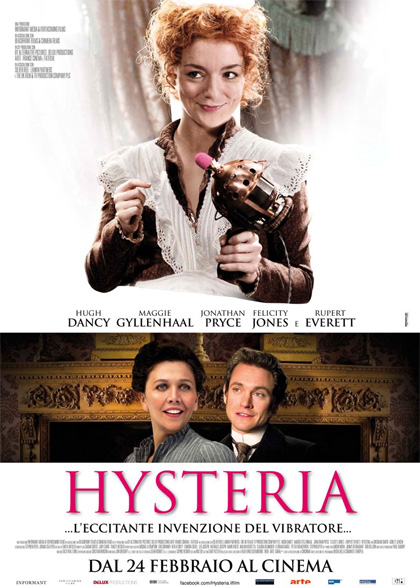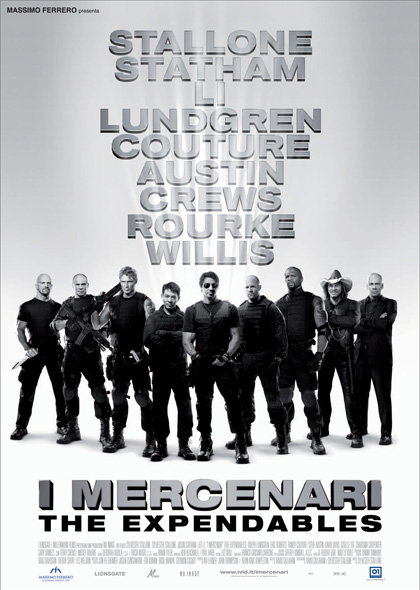Complimenti vivissimi allo scienziato sociale! Non tanto per la riluttanza ad accettare il mondo fuori dall'esperienza diretta - e ad accettare l'esperienza diretta per quel che è - quanto perché il titolo del docufilm chiarisce inequivocabilmente che la cosa può essere letta da un altro punto di vista, che mi è maledettamente familiare. Direi meglio che DEVE essere letta da quel punto di vista, che per il momento continuo a riscontrare in certe dinamiche e a rifiutare in altre.

"A divisive campaign," l'hanno chiamata. All'anima, verrebbe da dire alla romana, ed è proprio questo il punto: quando parli da anni del predominio incontrastato del paradigma esclusivo e dell'operazione della divisione, come puoi aspettarti che questa non si rivolga sempre più contro l'esistente che ironicamente vorrebbe usarla per tutelarsi? Da decenni assistiamo alla lacerazione di tutto ciò che non è "puro", omogeneo: stati plurinazionali, minoranze più o meno immaginarie, partiti politici e movimenti. Per quale motivo a un certo punto la spirale dovrebbe arrestarsi? Baudrillard l'ha detto magnificamente già nel 1976: "La definizione dell'Umano è, al livello della cultura, inesorabilmente ristretta: ogni progresso 'oggettivo' della civilizzazione verso l'universale ha corrisposto a una discriminazione più stretta, al punto che si può intravvedere il tempo dell'universalità definitiva dell'Uomo, che coinciderà con la scomunica di tutti gli uomini - e in cui la purezza del concetto splenderà sola nel vuoto".
Come pensare che qualcosa - qualsiasi cosa - resti unito quando il quadro generale all'interno del quale è nata si è lentamente alterato così da privilegiare unilateralmente, maniacalmente la divisione? L'urgenza della riscoperta dell'autoaggregazione, della coevoluzione è assoluta, ma come si potrà realizzarla in tempo, quando la gran parte dell'umanità non ascolta, non vuole ascoltare e non può più ascoltare per miopia, incapacità, vergogna, frustrazione? C'è in effetti ben poco da stare allegri.